Il maltosio o zucchero di malto o α-D-glucopiranosil-(1→4)-D-glucopiranoside è un disaccaride formato da due molecole di D-glucosio in forma piranosica. I due monosaccaridi sono uniti da un legame glicosidico α-(1→4), un legame covalente tra il C1 di una molecola di glucosio, ossia il suo carbonio anomerico emiacetalico, e l’atomo di ossigeno del gruppo ossidrilico legato al C4 dell’altra molecola di glucosio. Il legame glicosidico si verifica con ritenzione della configurazione sul C1, quindi alfa. Poiché uno dei residui di glucosio conserva un carbonio emiacetalico, il maltosio è uno è uno zucchero riducente.[10]
Viene prodotto nella porzione prossimale dell’intestino tenue, il duodeno, e nei semi in germinazione dall’azione delle amilasi sull’amido.[1][4]
A livello industriale deriva dall’idrolisi sia acida che enzimatica, catalizzata quest’ultima da amilasi sia fungine, ad esempio derivanti da Aspergillus oryzae, che batteriche, come quelle derivanti da Bacillus subtilis, di amidi di diverse origini.
Non è presente naturalmente nei cibi, e si ritrova solo in alcuni alimenti lavorati ai quali viene aggiunto durante la produzione. Si ritrova ad esempio in molti prodotti da forno e di pasticceria, dove vengono sfruttate le sue capacità di agire come dolcificante, stabilizzante e conservante.[16] Pertanto può essere annoverato tra gli additivi a uso alimentare consentiti dalle normative vigenti.[9]
Nel duodeno, grazie alla presenza di specifiche idrolasi nell’orletto a spazzola degli enterociti, il legame glicosidico α-(1→4) viene idrolizzato; il glucosio prodotto è quindi assorbito e passa nel circolo ematico.[14]
Indice
- Proprietà chimiche
- Funzioni
- Digestione intestinale
- Deficit della saccarasi-isomaltasi e maltasi-glucoamilasi
- Bibliografia
Proprietà chimiche
Come i disaccaridi lattosio, saccarosio e trealosio, ha formula molecolare C12H22O11 e massa molare di 342,30 g/mol.[9]
E’ molto solubile in acqua e la sua dolcezza è pari a circa il 33% di quella del saccarosio.
Al pari dei monosaccaridi, e del lattosio tra i disaccaridi, è uno zucchero riducente, in quanto il legame glicosidico α-(1→4) non interessa il carbonio emiacetalico di uno di due monomeri di glucosio che quindi, in soluzione, potrà aprirsi presentando un gruppo aldeidico libero.[10] Va comunque sottolineato che la forma a catena aperta è presente in quantità molto piccole.
Il carbonio anomerico libero presenta mutarotazione, sono cioè permesse entrambe le configurazione α e β, sebbene la configurazione β sia la forma anomerica predominante.
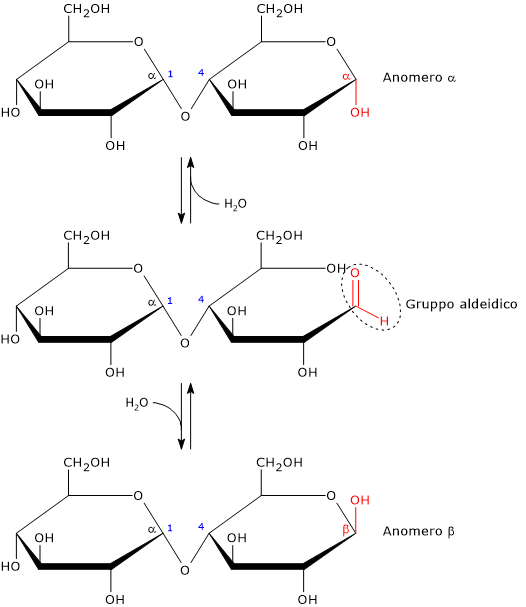
L’anomeria è un tipo di isomeria ottica caratteristica dei carboidrati. Due stereoisomeri di un monosaccaride ciclico sono definiti anomeri se differiscono solo per la configurazione del carbonio emiacetale o emichetale, che è chiamato carbonio anomerico o centro anomerico.[15]
Quello che accade è che la ciclizzazione intramolecolare dei monosaccaridi fa sì che l’atomo di carbonio del gruppo carbonile diventi un carbonio asimmetrico, ovvero un centro di chiralità. E in soluzione, in equilibrio con la loro forma aperta, si possono formare due anomeri:
- l’isomero α, se, durante la ciclizzazione, l’ossigeno del gruppo ossidrile attacca l’atomo di carbonio del gruppo carbonilico dal basso rispetto al piano sp2;
- l’isomero β, se l’ossigeno del gruppo ossidrile attacca l’atomo di carbonio del gruppo carbonilico dall’alto rispetto al piano sp2.
Funzioni
Nel corso della germinazione dei semi, l’amido presente nell’endosperma viene idrolizzato a dare maltosio e glucosio, zuccheri che andranno a supportare, assieme ad altri prodotti di idrolisi, la crescita della piantina in germinazione.[1]
Anche la produzione di bevande alcoliche derivanti dalla fermentazione dei cereali, la panificazione, o la produzione di preparati ad alto contenuto di maltosio, come gli sciroppi di glucosio e maltosio, sfruttano l’azione delle amilasi sugli amidi per il rilascio del disaccaride.[4]
In pasticceria viene utilizzato sia come dolcificante che stabilizzante per glasse, di cui non aumenta la dolcezza come invece farebbe il saccarosio. Inoltre, essendo in grado di inibire la retrogradazione dell’amido, può prolungarne la durata di conservazione.[16] Per questi motivi il maltosio può essere annoverato sia tra i conservanti i dolcificanti e gli stabilizzanti a uso alimentare.
E’ presente in molte preparazioni a base di carboidrati per l’alimentazione infantile.
Al di fuori dell’industria alimentare è utilizzato ad esempio come stabilizzante per le immunoglobuline.[9]
Digestione intestinale
Nell’uomo la digestione dei carboidrati ha inizio nel cavo orale, per azione della alfa-amilasi salivare, per poi proseguire e terminare nel duodeno, grazie a specifiche idrolasi quali la alfa-amilasi pancreatica e le idrolasi presenti nell’orletto a spazzola degli enterociti. L’azione combinata di questi enzimi permette l’idrolisi dei disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi nei monosaccaridi costituenti, ovvero fruttosio, glucosio, galattosio. Sempre nell’intestino tenue si verifica l’assorbimento dei monosaccaridi rilasciati, assorbimento mediato da specifici trasportatori proteici presenti nella membrana plasmatica dell’enterocita.[14]
L’azione della alfa-amilasi salivare e pancreatica sui due polisaccaridi componenti l’amido, amilosio e amilopectina, porta al rilascio di maltosio, maltotriosio, un oligosaccaride formato da tre molecole di glucosio unite da legami glicosidici α-(1→4), e, dall’amilopectina, anche di destrine α-limite, che sono polimeri di glucosio dove è presente almeno un legame glicosidico α-(1→6).[2][3]
Sebbene dalla digestione del glicogeno si possano ottenere maltosio, maltotriosio e destrine α-limite, il suo ruolo è trascurabile in quanto, dopo la morte dell’animale, va incontro a una rapida degradazione per la maggior parte a glucosio e acido lattico.
Il legame glicosidico α-(1→4) del maltosio viene idrolizzato in una reazione che può essere catalizzata da due enzimi: la saccarasi-isomaltasi (EC 3.2.1.48 e 3.2.1.10) e la maltasi-glucoamilasi o MAG (EC 3.2.1.20).[11]
- La saccarasi-isomaltasi è un enzima bifunzionale che presenta due siti attivi.[7] Un sito attivo, la saccarasi, è un’alfa-glicosidasi che idrolizza i legami glicosidici del maltosio, saccarosio, e di piccoli oligomeri di glucosio α-(1→4) legati e formati da un massimo di sei unità glucosidiche.[13] La saccarasi è responsabile di circa il 60-80% dell’attività maltasica presente nell’intestino tenue.[5] L’altro sito attivo, la isomaltasi o α-destrinasi, è una α-(1→6) glicosidasi che catalizza il rilascio di catene lineari dalle destrine α-limite.[12]
- Al pari della saccarasi-isomaltasi, la maltasi-glucoamilasi presenta due siti attivi, uno più specifico per il maltosio, e l’altro con una più ampia specificità di substrato, in grado di agire sugli oligomeri del glucosio. Entrambe i siti attivi catalizzano il rilascio di unità di glucosio.[11]
Si noti che l’azione sinergica della alfa-amilasi, della sucrasi-isomaltasi, e della maltasi-glucoamilasi è in grado di digerire completamente l’amido in unità di glucosio.
Deficit della saccarasi-isomaltasi e maltasi-glucoamilasi
Il deficit a carico di una delle glicosidasi dell’orletto a spazzola degli enterociti è in genere conseguenza di una condizione ereditaria, mentre possono essere tutte assenti a seguito di una infezione batterica, risolta la quale gradualmente si torna alla normalità.
Nel deficit congenito o primario della saccarasi-isomaltasi può essere interessata sia la saccarasi che l’isomaltasi, con accumulo, nel primo caso anche di maltosio. Analoga situazione si può presentare nel deficit congenito di maltasi-glucoamilasi, una condizione piuttosto rara, di cui sono stati descritti pochi casi in letteratura.[6]
In entrambe i casi, come anche a seguito di una infezione intestinale, i carboidrati non digeriti rimangono nel lume intestinale, dove poi possono essere in parte fermentati dai batteri del microbiota intestinale, che è parte del microbiota umano, a dare un eccesso di gas, come idrogeno, metano, e anidride carbonica, e acidi grassi a catena corta, quali l’acido acetico, l’acido propionico e l’acido butirrico.[8] La presenza di carboidrati non digeriti e dei prodotti della loro fermentazione, molti dei quali sono soluti osmoticamente attivi, provoca un aumento della pressione osmotica intraluminale, un afflusso di acqua nel lume e successiva diarrea.[17]
Il trattamento consiste nel ridurre o eliminare il maltosio dalla dieta.
Bibliografia
- ^ a b Andriotis V.M., Saalbach G., Waugh R., Field R.A., Smith A.M. The maltase involved in starch metabolism in barley endosperm is encoded by a single gene. PLoS One 2016;11(3):e0151642. doi:10.1371/journal.pone.0151642
- ^ Benjamin S., Smitha R.B., Jisha V.N., Pradeep S., Sajith S., Sreedevi S., Priji P., Unni K.N., Sarath Josh M.K. A monograph on amylases from Bacillus spp. Adv biosci biotechnol 2013;4:No.2. doi:10.4236/abb.2013.42032
- ^ Butterworth P.J., Warren F.J. and Ellis P.R. Human α-amylase and starch digestion: an interesting marriage. Starch/Stärke 2011;63:395-405. doi:10.1002/star.201000150
- ^ a b Garrett R.H., Grisham C.M. Biochemistry. 4th Edition. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010
- ^ Gericke B., Schecker N., Amiri M., Naim H.Y. Structure-function analysis of human sucrase-isomaltase identifies key residues required for catalytic activity. J Biol Chem 2017;292(26):11070-11078. doi:10.1074/jbc.M117.791939
- ^ Gurram B. – 11- Diarrhea. Editor(s): Kliegman R.M., Lye P.S., Bordini B.J., Toth H., Basel D. Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis. Elsevier, 2018. Pages 182-203.e1. doi:10.1016/B978-0-323-39956-2.00011-X
- ^ Hauri H.P., Quaroni A., Isselbacher K.J. Biogenesis of intestinal plasma membrane: posttranslational route and cleavage of sucrase-isomaltase. Proc Natl Acad Sci U S A 1979;76(10):5183-6. doi:10.1073/pnas.76.10.5183
- ^ Holtug K., Clausen M.R., Hove H., Christiansen J., Mortensen P.B. The colon in carbohydrate malabsorption: short-chain fatty acids, pH, and osmotic diarrhoea. Scand J Gastroenterol 1992;27(7):545-52. doi:10.3109/00365529209000118
- ^ a b c National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 6255, Maltose. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Maltose. Accessed Jan. 2, 2024
- ^ a b Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger. Principles of biochemistry. 6th Edition. W.H. Freeman and Company, 2012
- ^ a b Nichols B.L., Eldering J., Avery S., Hahn D., Quaroni A., Sterchi E. Human small intestinal maltase-glucoamylase cDNA cloning. Homology to sucrase-isomaltase. J Biol Chem 1998;273(5):3076-81. doi:10.1074/jbc.273.5.3076
- ^ Quezada-Calvillo R., Robayo-Torres C.C., Ao Z., Hamaker B.R., Quaroni A., Brayer G.D., Sterchi E.E., Baker S.S., Nichols B.L. Luminal substrate “brake” on mucosal maltase-glucoamylase activity regulates total rate of starch digestion to glucose. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007 Jul;45(1):32-43. doi:10.1097/MPG.0b013e31804216fc
- ^ Quezada-Calvillo R., Sim L., Ao Z., Hamaker B.R., Quaroni A., Brayer G.D., Sterchi E.E., Robayo-Torres C.C., Rose D.R., Nichols B.L. Luminal starch substrate “brake” on maltase-glucoamylase activity is located within the glucoamylase subunit. J Nutr 2008:138(4);685-92. doi:10.1093/jn/138.4.685
- ^ a b Rosenthal M.D., Glew R.H. Medical biochemistry: human metabolism in health and disease. A John Wiley & sons, Inc., Publication, 2009
- ^ Soderberg T. Organic chemistry with a biological emphasis. Volume II. Chemistry Publications. 2019 https://digitalcommons.morris.umn.edu/chem_facpubs/2
- ^ a b Wang S., Li C., Copeland L., Niu Q., Wang S. Starch Retrogradation: a comprehensive review. Compr Rev Food Sci Food Saf 2015;14:568-585. doi:10.1111/1541-4337.12143
- ^ Weijers H.A., va de Kamer J.H., Mossel D.A., Dicke W.K. Diarrhoea caused by deficiency of sugar-splitting enzymes. Lancet. 1960;2(7145):296-7. doi:10.1016/s0140-6736(60)91381-7